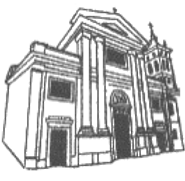Don Claudio Ticcioni 340 36 73 995
Le origini
Bibliografia: "La Chiesa di S. Matteo in Nave" - Giovanni AGOGLIA Lucca 1996
Il Signore disse a Mosè: - "Ordina ai figli di Israele che raccolgano per me un contributo. Da ogni uomo che sarà spinto dal proprio cuore alla generosità raccoglierete questo contributo. Ed ecco che cosa raccoglierete da loro come contributo: oro, argento e rame… Essi mi faranno un santuario e abiterò in mezzo a loro." Questo "ordine" è innato nel cuore degli uomini e dovunque vive un essere umano esiste un luogo ove si venera il proprio Dio, luogo voluto e realizzato con la partecipazione di tutti. Intorno all'VIII secolo i primi abitanti nella zona di Nave, poche famiglie, insieme a tutte le persone che risiedevano sulla riva sinistra del fiume Serchio (Ausere), facevano capo alla pieve di Flexo (Montuolo), che era intitolata a S. Martino. Questa parrocchia nel 970 fu data a livello, dall'allora vescovo Pietro, ad un tale Ildebrando con tutti i beni e le decime delle chiese sottoposte, tra cui la zona di Nave Eribrandi. Sempre nell'VIII secolo si diffuse il culto al Volto Santo non solo nei paesi limitrofi, ma in tutta Italia ed anche all'estero, tanto che la città diventò tappa obbligatoria per i pellegrini provenienti dal Nord diretti a Roma e viceversa.
Il territorio di Nave era attraversato dalla famosa via Romea, detta anche Francigena, che venendo da Sarzana, per Camaiore, Valpromaro, Piazzano, S. Macario, Carignano, S. Alessio, Ponte S. Pietro, entrava in Lucca da porta S. Donato, usciva da porta S. Pietro puntava su Massa Macinaia, entrava nel compitese e volgeva verso Altopascio e attraverso Galleno, Fucecchio, Empoli entrava in Val d'Elsa, toccava Poggibonsi e di lì per Siena Chiusi si immetteva nella Cassia diretta a Roma.
A Ponte S. Pietro si trovava il fiume Serchio (Ausere), dove un certo Eribrando svolgeva le funzioni di traghettatore. Gli introiti del traghettamento consentirono al nocchiero di acquistare vari appezzamenti di terra soprattutto alla parte sinistra del fiume.
Le persone che da Lucca dovevano percorrere la via Romea per dirigersi al Nord, per poter passare il fiume Serchio, dovevano portarsi "ad Navem Eribrandi". Anche dopo la costruzione del ponte sul Serchio, si continuò ad usare tale espressione, e come sempre succede nelle abitudini delle persone, finì per identificare i terreni di quella zona.
Questa è una deduzione di chi scrive, future e più approfondite ricerche potranno chiarire la questione, che non è del tutto infondata, basta leggere in calce a questo capitolo alcune dizioni riprese da una ricerca del signor Spiezia Giovanni.
L'impero di Carlo Magno, che aveva raggiunto tanto fulgore e grandezza, nonostante gli auspici solenni e le disposizioni del suo fondatore, si dissolse così come era stato creato, come tutte le organizzazioni eterogenee e disorganiche di questo mondo. Fu una corsa a vendere e ad accaparrare titoli e prebende, che si moltiplicarono a dismisura.
Tra i beneficiari di queste elargizioni, lautamente remunerate, troviamo anche il discendente di Eribrando, proprietario, come detto, di buona parte delle terre di Nave, che diventerà Marchese.
Ritorniamo ad Eribrando, questi non si interessava solamente del traghettamento dei pellegrini, pensò anche alle loro esigenze fisiche e alla loro salute, infatti costruì a Ponte S. Pietro un ospizio per alloggiarli ed eventualmente curarli.
Queste istituzioni, paragonabili agli enti della nostra epoca, allora venivano denominate Opere, amministrate da un responsabile che era chiamato Operaro. All'Opera potevano andare benefici, eredità, offerte, elemosine oltre alle tasse che l'Operaro riteneva di imporre alle persone che utilizzavano la struttura, per le spese e il mantenimento della stessa.
Il ponte di legno che subentrò al traghetto fu opera del Marchese e venne chiamato: "Ponte del Marchese". Anche per questa realizzazione si costituì l'Opera che provvedeva all'amministrazione e alla gestione della medesima.
Svanita la paura per "la fine del mondo" profetizzata per gli albori dell'anno 1000, si registrò in Italia una ripresa generale. Non si sentiva parlare più di grandi pestilenze. La malaria era abbastanza circoscritta. Non' si registravano più ostacoli biologici all'incremento naturale della popolazione. Le grandi battaglie, un altro ostacolo alla crescita, assunsero un ruolo di scarso rilievo, in quanto non si allestivano più grandi eserciti, né si assistette a battaglie campali.
Le campagne abbandonate durante il periodo delle invasioni barbariche e durante le continue guerre, ritornarono ad essere abitate e coltivate. Si registrò un rifiorire di vita: località prima poco meno che deserte videro sorgere borghi.
Si viveva anche una forte rinascita religiosa testimoniata dalla creazione di vari ordini: i Benedettini Riformati, i Camaldolesi, i Vallomb rosani.
Questo progresso economico, accompagnato dal risveglio di sentimenti religiosi, investì anche Lucca, soprattutto per le iniziative assunte dal vescovo dell'epoca Giovanni II, nominato a capo della Chiesa lucchese nel 1023.
Nacquero le Canoniche di S. Maria a Monte e di S. Genesio, di S. Frediano, di S. Piero Maggiore, di S. Pietro di Pozzeveri. Il Vescovo incoraggiò e sostenne la costruzione di chiese, ospedali, monasteri in città e fuori.
Le terre della zona di Nave, costeggiate dal fiume, erano facilmente irrigabili e rappresentarono per molte famiglie una sospirata sistemazione.
La comunità cresceva, conseguiva una certa indipendenza economica grazie allo smercio dei prodotti della terra, nasceva una forma di aggregazione. Diventò sempre più pressante il desiderio del Signore esplicitato a Mosè, rivendicarono autonomia e vollero una loro chiesa. Si distaccarono dalla pieve di Montuolo, costruendone una propria, che fu dedicata a S. Matteo Apostolo.
In un documento del 1085 si trova la prima traccia dell'esistenza della parrocchia, si parla di una donazione da parte del chierico Melondo alla parrocchia di S. Matteo a Nave.
Il rettore di Ponte S. Pietro, nell'anno 1116, mal digerendo che le terre e i fabbricati di proprietà del Marchese del Ponte, al di là del Serchio, coltivate dai Navesi, fossero appannaggio della parrocchia di S. Matteo, intentò causa per accaparrarsi quelle rendite. Il collegio giudicante, composto dal giudice Gualando assistito dai consoli Ardicio e Gerardo, rigettò la richiesta del parroco di Ponte S. Pietro confermando la legalità dei diritti, che erano stati e dovevano continuare ad essere di pertinenza del pievano di S. Matteo a Nave.
Il Serchio, quantunque assicurasse tanta acqua che consentiva l'irrigazione, necessaria per le coltivazioni intensive, rappresentava sempre un pubblico pericolo nei periodi di piena, in quanto spesso rompeva gli argini allagando tutto e costringendo la gente a fuggire. Ma, dopo il ritiro dell'acqua, si ritornava ai propri poderi per riprendere le coltivazioni su un terreno rinnovato e reso più fertile.
Questa situazione certamente dissuadeva le persone a trasferirsi nella zona, per cui la popolazione è stata sempre contenuta, fino al termine del secolo XVIII, quando venne realizzato il progetto del Nottolini sul rafforzamento degli argini.
Nel secolo XIV, durante la guerra tra Firenze e Lucca, esattamente nell'anno 1336, Pietro De Rossi a capo di un esercitò arrivò fino alle mura di Lucca "guastando e rubando parecchie terre" per circa sei miglia intorno alla città. Tra i paesi saccheggiati troviamo: Montuolo, S. Michele a Miati, S. Maria di Fagnano, Salissimo, S. Angelo in Campo. S. Matteo a Nave, Saltocchio, S. Pancrazio e S. Concordio che "furono arsi del tutto dai nemici".
Ma i Navesi non si scoraggiarono, volenterosi, tenaci e generosi si rimboccarono le mani e ricominciarono.
Riporto di seguito le citazioni raccolte da Giovanni Spiezia in un documento dattiloscritto:
Alcune ricerche sulla "Comunità di Nave" - Archivio di Stato Lucca - Voce Nave Dai documenti di archivio a partire dall'anno 970 all'anno 1081.
- pezzo di terra a pastino e campo "Prope nave que dicitur Erivrandi" -Doc. n. 223 - anno 1071 - 17 settembre;
- possiede fuori di Lucca in "Nave vocabolo Herivrandi" - Doc. n. 267 anno - 1067 - 15 febbraio;
- terra a campo e orticello presso "Nave Erivrandi" - Doc. n. 276 - anno 1078 - 7 gennaio;
- nonché la metà di due pezzi di terra in " Nave Erivrandi" - Doc. n. 306 - anno 1081- 25 agosto;
Dall'anno 1082 al 1153 si legge.
- in "Nave presso Ponte Marchionis" - Doc. n. 552 - anno 1114 - 8 novembre;
- tutte le terre, cose, ecc.. che possiede in "Nave", Doc. n. 622 - anno 1150 - 12 luglio;
- pezzo di terra ad "ortale" con alberi in "Nave presso Ponte Marchionis" - Doc. n_ 637 - anno 1151- 6 agosto;
- un pezzo di terra ad ortale e campo con tre capanne ed alberi, e "cum palmento et tino, in Nave presso Ponte Marchionis" Doc. n. 661 - anno 1153 - 21 aprile.